Divulgazione scientifica e mass media - Attenzione ai rischi.
Negli ultimi anni grazie ad internet le modalità di comunicazione si sono moltiplicate, ma di contro chiunque può essere fonte di informazioni. Attraverso i social network, le persone condividono quello che vivono in prima persona attraverso una sorta di giornalismo collaborativo, molto utile per fatti di cronaca ed attualità ma non per la divulgazione delle ricerche scientifiche, i cui risultati prima della pubblicazione devono essere verificati da esperti di settore.
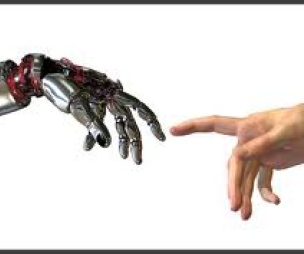
Purtroppo le ricerche scientifiche non sono facilmente accessibili al grande pubblico, in quanto generalmente sono riportate in un linguaggio altamente specifico e pubblicati in riviste peer reviewed prevalentemente pubblicate in Inglese. La mancata divulgazione dei risultati delle attività di ricerca ha acuito il distacco tra scienza e società ed ha favorito la diffusione d’informazioni scientifiche non corrette da parte dei media, che hanno contributo ad alimentare false speranze in campo medico e correnti di opinioni su fatti scientifici non verificati.
Un’indagine del 2011 sulla comunicazione scientifica svolta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha evidenziato che i ricercatori del CNR partecipano ad attività di comunicazione rivolte ad aziende e amministrazioni, ed in secondo luogo studenti (L’Astorina, 2011). Le attività che prevedono il coinvolgimento diretto del pubblico sono una piccola percentuale dell’attività divulgativa e concentrate su pochi argomenti di attenzione sociale, come l’ambiente e la salute. La poca comunicatività degli enti di ricerca si contrappone alla voglia di conoscenza dei cittadini, che sempre più spesso utilizzano il web per soddisfare le proprie curiosità o necessità spesso "inciampando" in siti non attendibili.
Purtroppo all’interno del panorama dei siti internet che si occupano di divulgazione scientifica mancano quasi del tutto le Università, ovvero i luoghi in cui è condotta gran parte della ricerca scientifica nazionale, principalmente perché l'attività divulgativa non è rilevante ai fini della carriera universitaria. (Carrada, 2005) La divulgazione “Universitaria” non dovrebbe essere una forma di giornalismo scientifico, che si occupa di informare sui retroscena e ricadute di nuove scoperte scientifiche, ma un‘attività di apprendimento a lungo termine, con lo scopo di favorire lo sviluppo di competenze scientifiche in soggetti non in età formativa/scolastica. La condivisione del lavoro dei ricercatori con i cittadini contribuirebbe a far comprendere meglio l'importanza della ricerca scientifica, soprattutto in campi in cui le ricadute nella vita di tutti i giorni sono meno immediate. Una corretta attività divulgativa permetterebbe ai cittadini di poter effettuare scelte consapevoli su importanti temi scientifici, ed assumere un atteggiamento critico rispetto alla miriade di informazioni spesso confuse reperibili sui mass media.
Bibliografia
- L’Astorina A., (2011). Researchers as communicators: A survey on the public engagement of Italian CNR research institutions. In: Adriana Valente A. (ed.), SHARING SCIENCE Researchers’ ideas and practices of public communication, University press series.
- Carrada G., (2005). Comunicare la scienza: kit di sopravvivenza per ricercatori. Vol. 12. Alpha Test.
- http://informa.airicerca.org/2014/09/23/la-divulgazione-scientifica-italiana-sul-web-a-che-punto-siamo/
Autore: Teresita Gravina
Teresita Gravina è laureata in Geologia e in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente ed il Territorio e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra. Attualmente è docente a contratto di Geologia Ambientale presso l'Università Telematica Guglielmo Marconi. E’ ideatrice e curatrice di “Sustainability” (http://www.sunability.unina2.it), progetto di divulgazione scientifica delle ricerche svolte presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (DISTABIF) della seconda Università di Napoli.

Letture consigliate
Recentemente
CIBI ULTRA-PROCESSATI E RISCHIO DI CANCRO: UNA NUOVA PERICOLOSA RELAZIONE
Pubblicato il: 15/10/2024
UNA BREVE ATTIVITA' FISICA INTENSA, RIDUCE IL RISCHIO DI MORTE DEI PAZIENTI CON ALZHEIMER
Pubblicato il: 16/02/2024
Incidenti nucleari e salute pubblica
Pubblicato il: 21/10/2024
Le polveri sottili condizionano negativamente la nostra aspettativa di vita.
Pubblicato il: 08/07/2024
Le immagini a corredo degli articoli riprodotti su fivehundredwords.it provengono da ricerche effettuate su Google Image